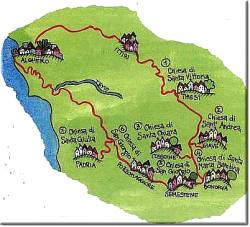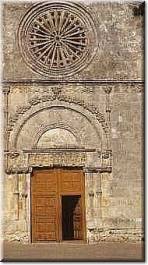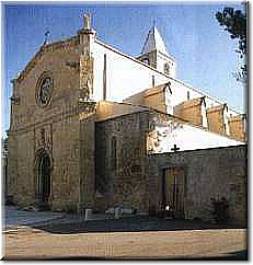Gotico di Sardegna |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Benché la conquista aragonese
risalga quanto meno al 1436, è solo verso l'inizio del XVI secolo che nel
Nord Sardegna incomincia ad affermarsi con chiarezza uno stile di marca
iberica nell'architettura religiosa: uno stile che può già
definirsi tardo-gotico al suo primo apparire e che resisterà nell'isola per oltre
un secolo. In una piccola area del Meilogu sorsero allora ben nove chiese
parrocchiali che, per quanto disperse nel tempo sull'arco di circa cento
anni, mostrano nel loro insieme un'unità stilistica e una continuità di forme
davvero eccezionali. Accogliendo e come cristallizzando nel tempo i moduli
gotico-aragonesi, adattandoli al gusto della religiosità locale, innervandoli
a poco a poco di suggestioni rinascimentali e manieristiche, le maestranze
catalane immigrate e quelle indigene che ne rilevarono l'eredità finirono col
disegnare i tratti di un'architettura d'importazione e insieme
paradossalmente originale, fortemente connotata nel suo particolarismo e
sottilmente diversa da ogni altra: un'architettura che, senza forzare la
realtà e la storia, può a ragione definirsi sardo-aragonese o gotico-sarda,
se non addirittura (considerando gli stilemi inconfondibili di quest'area
ristretta) gotico-logudorese. L'elegante portale gigliato inquadrato da due
robusti contrafforti laterali, spesso sporgenti in due ali d'effetto
scenografico, e l'interno mononavato, suddiviso in campate voltate quasi
sempre a crociera, sono per così dire il corredo genetico essenziale di
queste sette chiese (cui vanno aggiunte, per completare la collezione, le
parrocchiali di Torralba e Cheremule, escluse dal nostro breve itinerario):
su questa solida intelaiatura l'evoluzione del gusto e l'estro degli uomini
si sono divertiti a innestare variazioni di ogni sorta, alternando sulle
facciate gli ornamenti di reminiscenza romanica a quelli d'ispirazione
moresca, e soprattutto arricchendo gli interni di decorazioni fantasiose, di
cappelle laterali che sembrano talvolta distaccarsi dal corpo dell'edificio
come piccole chiese a sé stanti, abbigliando le colonne di plinti e capitelli,
decorando le volte di formelle o rivestendole di maioliche policrome in
rilievo. Un viaggio monografico in questo piccolo universo poco noto di arte
marginale e dolcemente tardiva permette di acquisire, strato dopo strato, la
consapevolezza di come una cultura, trapiantata in un'altra terra, ne
assorba i sapori. 1. Thiesi: Chiesa parrocchiale
di Santa Vittoria (1590 circa). Il nostro
itinerario, che può essere immaginato con partenza e arrivo ad Alghero, più o
meno equidistante (una cinquantina di chilometri) dai due punti estremi, ha
la sua prima meta nel centro di Thiesi. Un primo elemento di originalità
della parrocchiale di Santa Vittoria è dato dall'asimmetria della facciata
che, mentre su un lato si protende nella quinta obliqua e molto accentuata
del contrafforte, dal lato opposto si addossa alla base quadrata del campanile.
La facciata della chiesa di Santa Vittoria di Thiesi Bellissimo
il rosone a raggiera, dai cui trafori traspaiono gli spicchi policromi della
vetrata. Luminoso l'interno, la cui unica navata è suddivisa da agili archi a
sesto acuto in quattro campate voltate a crociera. Il prezioso pulpito
ligneo, della stessa mano di quello di Ardara, è del primo Seicento. 2. Giave: Chiesa parrocchiale
di Sant'Andrea (1583 circa). Dell'originario impianto
romanico la chiesa conserva il disegno nitido della modesta facciata a
spioventi, liscia e nuda, sulla quale il gotico portale gigliato risalta con
particolare evidenza. I contrafforti laterali, qui, sono in linea con la
facciata. Nel tardo Seicento la parrocchiale di Giave ha subito profondi
rimaneggiamenti, sia all'esterno (finestra quadrata che sovrasta il portale,
ordini superiori - a pianta ottagonale - e guglia conica del campanile) sia
soprattutto all'interno dove, nella sagrestia di sinistra, si cela l'elemento
di maggiore originalità dell'edificio: due fi lari di colonne dai plinti e
dai capitelli fantasiosamente elaborati, ornate da teste di serafini nelle
modanature superiori e sormontate da una fila di formelle in rilievo. Questo
ampliamento risale a un periodo compreso fra l'ultimo decennio del XVII e il
primo del XVIII secolo e costituisce un esempio suggestivo di come, in
Sardegna, il gusto barocco si eserciti con trattenuta esuberanza sopra linee
e forme ancora tardorinascimentali. Per il resto anche l'interno mononavato,
suddiviso in cinque campate voltate a botte, tradisce l'origine
gotico-aragonese. 3. Cossoine: Chiesa
parrocchiale di Santa Chiara (ultimo quarto del XVI secolo). Le due semicolonne che,
prolungando fino alla cornice i pilastrini esterni del portale gigliato,
sostengono due teste di mostri denunciano la filiazione diretta della
parrocchiale di Cossoine dal raffinato modello di Padria, ribadita dal
rosone dall'ampia cornice modanata. Nell'interno, sopra lo stilema gotico-aragonese
dell'aula mononavata partita in tré campate voltate a botte, la fantasia
fervida e talora ingenua degli artigiani locali si è sbizzarrita a ornare i
capitelli di sculture sacre e profane, di gusto e plasticità
rinascimentali, raffiguranti angeli, aquile, suonatori di liuto, ballerini.
In una delle cappelle laterali, infine, la volta è decorata con formelle in
rilievo, estremamente variate nei colori e nelle figurazioni. 4. Bonorva: Chiesa parrocchiale di Santa Maria Bambina (1582 circa). La derivazione
gotico-aragonese del portale gigliato è confermata dai due pilastrini che si
prolungano lungo la facciata fino alla cornice ad archetti: eppure l'arco a
tutto sesto è sormontato da un architrave con timpano triangolare, di chiara
ispirazione rinascimentale. L'interno è, secondo il modulo ormai noto, mononavato
e suddiviso in cinque campate da archi a sesto acuto. Anche qui, però, la
mano dell'artigiano e il gusto della religiosità popolare si manifestano
liberamente nelle sculture che adornano i capitelli, specie quelli della
prima campata. Interessante anche, nella prima cappella a sinistra, il
fantasioso ornamento a formelle sulla cornice della volta. 5. Semestene: Chiesa parrocchiale
di San Giorgio (1620-1630 circa). La parrocchiale di Semestene è
la più tarda fra quelle che compongo no questa piccola famiglia e, nella sua
sobria ma non banale linearità, costituisce un esempio di come l'architettura
sarda trapassi dal tardo-gotico al tardo-rinascimentale sviluppando,
nell'anacronismo inevitabile dell'isolamento, caratteri di sincretismo
stilistico Costruita in posizione scenografica, con magnifica vista sui mossi paesaggi vulcanici del Meìlogu, la parrocchiale di San Giorgio domina sul piccolo villaggio di Semestene La facciata di calcare chiaro,
suddivisa in specchi da paraste, incornicia il bei portale inquadrato a sua
volta fra due paraste scanalate e sormontato dal timpano e dalla finestra
rettangolare in asse. Nulla, all'esterno, lascia indovinare l'impianto
gotico-aragonese che si rende invece manifesto all'interno: l'aula
mononavata, fedele a un modello che resiste immutato da oltre un secolo, è
ripartita in quattro campate, tre delle quali voltate a botte, una a
crociera. La chiesa sorge in posizione scenografica, alta su una terrazza
cui si accede da un'ampia scalinata, e costituisce un monumento di
sorprendente bellezza e importanza in un minuscolo paese che contava, al
1998, duecentocinquantadue abitanti. 6. Pozzomaggiore: Chiesa
parrocchiale di San Giorgio (1550 circa). La facciata si apre fra i
contrafforti laterali obliqui che, esplorando fino all'estremo limite le
potenzialità scenografiche del modello, si prolungano in due quinte che
fanno l'effetto di grandi ali spalancate. Sopra il bei portale gigliato corre
un ampio fregio ad archi intrecciati che, come la cornice, si prolunga nei
contrafforti, ripartendo la facciata in due ordini: in quello superiore, ai
lati del grande rosone, i contrafforti si prolungano in due ali più corte,
tagliate quasi ad angolo retto, la cui ipotcnusa svasata accentua lo slancio
verticale del frontone a spioventi. L'interno è rigorosamente mono-navato,
suddiviso in cinque campate voltate a crociera, con eleganti ornamenti nei
capitelli dei pilastri e nelle chiavi di volta degli archi. Nella seconda
cappella a sinistra la volta a botte è tutta rivestita di tormelle quadrate
in rilievo, intagliate nei più svariati motivi floreali e zoomorfi a comporre
un'esuberante fantasia di forme e di colori. 7. Padria: Chiesa parrocchiale
di Santa Giulia (1520 circa). Di questo
nutrito gruppo di chiese gotico-aragonesi del Meilogu la parrocchiale La parrocchiale di Santa Giulia di Padria è uno dei capolavori dell'architettura gotico-aragonese in Sardegna La facciata in conci di arenaria dorata, chiusa fra i contrafforti obliqui che si prolungano sopra la cornice in gradoni ornati da due statue di profeti, il portale gigliato con i due pilastrini che si slanciano oltre l'arco a tutto sesto a sostenere due figure mostruose, il magnifico campanile a canna quadrata, l'interno mononavato ripartito in cinque campate voltate a crociera, i capitelli e le mensoline scolpiti con figure di angeli e di suonatori di liuto o di flauto, ogni elemento, si può dire, di questo raffinato gioiello dell'architettura catalana in Sardegna è servito da modello, mai eguagliato, per le sue eccellenti imitazioni e variazioni. Scoprirla per ultima è come veder confluire, andando a ritroso nel tempo, gli esercizi di stile nell'esemplarità del capolavoro: a conferma che, nell'arte, la perfezione si presenta spesso al principio, ma può essere gustata appieno soltanto alla fine. |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|