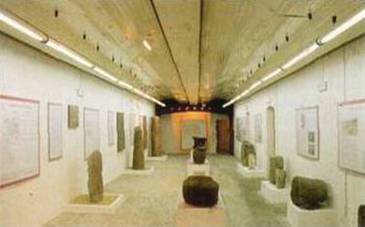Bonorva
|
|
|
|
Altitudine: m 508 Superficie: kmq 149,55
Abitanti: 4.257 |
|
Una sala dei museo civico archeologico |
|
Il paese, il maggiore e probabilmente
il più ricco del Meilogu, è posto a mezza costa, su un pendio ripido e in più
punti aspro: ha alle spalle il vastissimo altipiano di Campeda e davanti, ai
suoi piedi, l'ampia piana di Santa Lucia che si allarga verso oriente.
L'abitato, di grande decoro, rivela per chiari segni
un solido benessere e un grado elevato di sviluppo civile: qui, prima che
in molti altri luoghi della Sardegna pastorale, l'allevamento del bestiame
adottò tecniche evolute; qui si sviluppò una borghesia che alle solide basi
economiche univa vivaci inclinazioni culturali e una speciale attenzione per
la cultura tradizionale. Patria di studiosi della lingua sarda e di poeti
dialettali (il maggiore, autore di composizioni alle quali viene riconosciuta
grande dignità letteraria, fu Paolo Mossa,
assassinato nel 1892 da due banditi, Francesco Derosas e Pietro Angius,
assoldati come sicari da suoi misteriosi nemici), Bonorva si ritiene custode
legittima della purezza della lingua logudorese. Qui è ancora attiva
l'industria casearia, il cui primo stabilimento vi fu impiantato fin dalla
fine dell'Ottocento. Qualche beneficio deriva al paese anche dallo
sfruttamento delle acque minerali delle Fonti di
Santa Lucia. Di pregio notevole la chiesa parrocchiale di Santa Maria
Bambina, bella costruzione gotico-aragonese del
XVI secolo; ha un bei portale ad arco sormontato da un ornamento di forma
triangolare di ispirazione classica. L'interno, a navata unica, è suddiviso
in cinque campate, secondo uno schema ricorrente nell'architettura
sardo-aragonese del Meilogu. Lo sviluppo economico e civile di Bonorva, che
acquistò rapidamente importanza come centro agricolo, ebbe inizio fra il
Cinquecento e il quasi tutte riutilizzate in età
altomedioevale. Tra quelle visitabili sono la Tomba detta del
"Capo", che in periodo paleocristiano fu
trasformata in chiesa ed ha affreschi bizantini alle pareti, e la
Tomba a Camera, con copertura a due spioventi che sembra riprodurre il tetto
di una casa prenuragica. Fra gli ipogei scavati nel pianoro
il più bello e articolato è quello che conserva il focolare rituale. In
posizione dominante rispetto alla Necropoli di Sant'Andrea Priu si trova un grande masso a forma di toro, conosciuto come il
"Toro Sacro", o anche come il "Campanile". È probabile
che la singolare "scultura", mancante però della testa, sia stata
modellata dagli agenti atmosferici e poi rifinita dall'uomo forse con intenti
religiosi: la figura del toro,
simbolo della fertilità e della vita, è spesso presente nelle domus de janas
risalenti all'Età del Rame (3500 - 2700 a.C.). A sud dell'abitato, infine, si
trovano due muraglie difensive che sembrano fronteggiarsi: una, sulla sommità
dell'altipiano, di costruzione punica, la seconda, più a est, di fattura
nuragica: sembra che si possa dedurne che, intorno al V secolo a.C., la penetrazione
punica si arrestasse al limite dell'altipiano, contrastata dai popoli
nuragici. Nel 1999 è stato allestito, nei locali
dell'ex convento francescano, il Museo civico archeologico, nel quale, col
supporto di reperti di grande valore scientifico e di pannelli didascalici,
vengono ricostruite, secondo un itinerario a ritroso
nel tempo, la storia e la preistoria del territorio, dall'età moderna a
quelle più remote.
|
|
La gallina prataiola La gallina prataiola è
presente, nel Nord Sardegna, soltanto in due aree limitate, nei tenitori
comunali di Bonorva (nell'oasi faunistica di Monte Cacau) e di Ozieri (in un'oasi del WWF). Animale di dimensioni
medio-grandi, con un'apertura alare di quasi 90 centìmetri, la gallina
prataiola dimora negli ambienti aperti, coltivi estensivi, steppe e macchia
mediterranea diradata. Camminatore sulle piccole distanze,
tende a mantenersi al coperto nell'erba, alzandosi in volo con una certa
riluttanza. L'osservazione può essere effettuata
più facilmente all'inizio delta primavera, durante il periodo dei
corteggiamenti, quando i maschi, gonfiando le piume e aprendo a ventaglio la
coda. compiono balzi verticali ben visibili anche a
distanza. La popolazione italiana, dopo l'estinzione in Sicilia e la quasi
totale scomparsa dalla Puglia, è all'incirca confinata esclusivamente in
Sardegna, dove è concentrata una delle più vitati
popolazioni conosciute in Europa, stimata in 2000-2500 individui, con
una tendenza dinamica volta alla stabilità. |